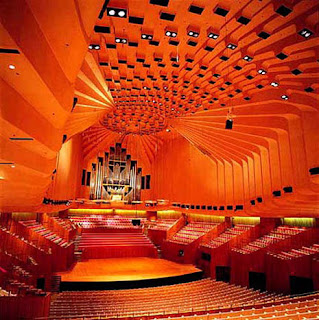L'Acropoli è un altopiano calcareo che a Sud è a strapiombo sul mare, mentre a Nord si restringe fino a m 140. L'insediamento, di forma grossomodo trapezoidale, fu ampliato verso N alla fine del VI secolo a.C. con un formidabile muraglione a gradini (h. m 11 ca.), e circondato da mura - più volte restaurate e modificate - formate da cortine in blocchi squadrati con un riempimento di pietrame (emplècton), e scandite da 5 torri e 4 porte. A Nord, l'acropoli presenta delle fortificazioni (vedi sotto) con contromuro e torri, databili all'inizio del IV sec. a.C.
Presso l'ingresso all'acropoli vi è la cd. Torre di Polluce che fu costruita nel XVI secolo contro i corsari, sui resti di una torre o faro antico.
L' impianto urbano è suddiviso in quartieri da due strade principali (la. m 9) che si incrociano ad angolo retto (quella N-S lu. m 425; quella E-W lu. m 338), intersecate a loro volta - ogni m 32 - da altre vie minori (la. m 5). Questa sistemazione urbanistica - che riproduce quella più antica - risale però al IV sec. a.C. cioè alla Selinunte punica.
Ai primi anni della colonia, invece, sono da attribuire diverse are e piccoli santuari innalzati sull'acropoli, sostituiti circa cinquant'anni più tardi da templi più grandi e duraturi; il primo di essi sembra sia stato il cd. mègaron nei pressi dei Templi B e C.
Ancora incerta resta la localizzazione dell' agorà (che invece altri studiosi ipotizzano che si trovasse a N nell'area del centro abitato).
Davanti al Tempio O si è rinvenuta un' area sacrificale punica - posteriore alla conquista del 409 a.C. - caratterizzata da ambienti costruiti con muretti a secco, all'interno dei quali erano depositati vasi contenenti ceneri, ed anfore a siluro di tipo cartaginese.
Sulla collina dell'acropoli sono stati rinvenuti i resti di numerosi templi di ordine dorico.
Il Tempio O ed il Tempio A
Di cui restano pochi avanzi: il basamento, qualche rocchio e l'ara - furono costruiti tra il 490 ed il 460 a.C., hanno una struttura pressoché identica tra loro, simile a quella del Tempio E sulla collina orientale. Presentano un peristilio (lu. m 40,20; la. m 16,20) di 6 x 14 colonne (h. m 6,23). L'interno è caratterizzato da un pronao in antis, da una cella con adyton, e da un opistodomo in antis separato dalla cella; la cella era di un gradino più alta del pronao, e l'adyton era di un gradino più alto della cella. Nel muro tra pronao e cella del Tempio A vi erano due scale a chiocciola che portavano alla galleria (o piano) superiore. Il pronao del Tempio A ha un pavimento a mosaico dove sono rappresentati la figura simbolica della dea fenicia Tanit, un caduceo, il sole, una corona ed una testa bovina: esso testimonia il riutilizzo dell'ambiente in epoca punica come luogo religioso o come abitazione. Il Tempio O era dedicato a Poseidon, piuttosto che non ad Atena (Moscati); il Tempio A ai Dioscuri, piuttosto che non ad Apollo (Moscati).
A m 34 ad E del Tempio A vi sono i resti dell' ingresso monumentale all'area: si tratta di un propileo con pianta a forma di T, consistente in un corpo avanzato rettangolare (di m 13 x 5,60) con peristilio di 5 x 12 colonne, ed in un altro corpo pure rettangolare (di m 6,78 x 7,25).
Superata la strada E-W si entra nella seconda area sacra, posta a N della precedente. Prima di giungere al Tempio C, a S di esso, vi è un Sacello (Mègaron) (lu. m 17,65; la. m 5,50), che risale al 580-570 a.C., avente la struttura arcaica del mègaron, forse destinato a conservare le offerte dei fedeli. Privo di pronao, ha l'entrata ad E che dà direttamente nella cella (al centro della quale vi sono due basi per le colonne lignee che sostenevano il tetto), racchiusa in fondo da un adyton quadrato, al quale venne aggiunto in epoca successiva un terzo ambiente. Il sacello era forse dedicato a Demetra Tesmofòros (Coarelli-Torelli).
Tempio B
Di epoca ellenistica, piccolo (lu. m 8,40; la. m 4,60) ed in cattive condizioni. Consisteva in una edicola prostila di 4 colonne cui si accedeva per una scala di 9 gradini, con pronao e cella. Nel 1824 mostrava ancora chiare tracce degli intonaci policromi. Costruito probabilmente intorno al 250 a.C., poco tempo prima che Selinunte venisse definitivamente evacuata, rappresenta il solo edificio religioso che attesta la modesta rinascita della città dopo la sua distruzione. Oscura resta la sua destinazione: in passato si era creduto trattarsi dell' heroon (tempio sede di un culto eroico) di Empedocle, bonificatore delle paludi selinuntine[8], ipotesi non più sostenibile per la cronologia dell'edificio; oggi si pensa più ad un culto punico fortemente ellenizzato, come quelli di Demetra o di Asclepio-Eshmun.
Pianta del Tempio C

Il Tempio C è il più antico in quest'area, e risale al 550 a.C. Nel 1925-27 sono state ricomposte e rialzate sul lato N numerose colonne (per la precisione 14 colonne su 17) con parte della trabeazione. Presenta un peristilio (lu. m 63,70; la. m 24) di 6 x 17 colonne (h. m 8,62). È caratterizzato ad E dall'ingresso preceduto da una scalinata di 8 gradini, un vestibolo con una seconda fila di colonne, quindi il pronao, la cella e l'adyton collegati in un insieme stretto e lungo (carattere arcaico); ha sostanzialmente la stessa planimetria del Tempio F sulla collina orientale. Mostra in diversi elementi una certa inesperienza e lo sforzo di giungere alla perfezione tecnica del tempio dorico: p.es. le colonne sono tozze e massicce, alcune di esse sono ancora monolitiche, manca l' èntasis (rigonfiamento della colonna), vi sono variazioni nel numero delle scanalature, oscillazioni nelle misure degli intercolumni, le colonne angolari hanno un diametro maggiore delle altre, ecc. Nel tempio sono stati rinvenuti: dalla decorazione della cornice alcuni frammenti di terrecotte policrome (rosso, bruno, porpora); dalla decorazione del frontone un gigantesco gorgoneion fittile (h. m 2,50); dalla facciata tre metope che rappresentano: Perseo, alla presenza di Atena, in atto di decapitare Gorgone che stringe a sé Pegaso; Eracle, catturati i Cèrcopi (folletti-ladri), li porta via sospesi ad una pertica a testa in giù; la quadriga di Apollo vista frontalmente (il dio era affiancato dalle figure di Helios e Selene: lacunose), che sono tutte al Museo Archeologico di Palermo. Il Tempio C - che probabilmente aveva anche una funzione di archivio: infatti vi furono ritrovati centinaia di sigilli - era dedicato ad Apollo (rinvenimento dell'iscrizione IG XIV, 269), piuttosto che non ad Eracle (Guido).
Ad E del Tempio C vi è il suo grande altare rettangolare (lu. m 20,40; la. m 8) di cui restano le fondazioni e qualche gradino, e poi l'area dell' Agorà ellenistica; poco oltre i resti delle case, la terrazza è limitata da un portico dorico (lu. m 57; la. m 2,80) che si affaccia su di un imponente tratto del muro di sostegno dell'acropoli.
Tempio D
Si data al 540 a.C., e si affaccia col suo fronte W direttamente sulla strada N-S. Presenta un peristilio (lu. m 56; la. m 24) di 6 x 13 colonne (h. m 7,51). È caratterizzato da un pronao in antis, una cella allungata conclusa con l'adyton. È più progredito del Tempio C (le colonne sono lievemente inclinate, più slanciate e con èntasis; il vestibolo è sostituito da un pronao distilo in antis), ma mostra ancora incertezza nelle misure fra gli intercolumni e nei diametri delle colonne, come pure nel numero delle scanalature. Come già il Tempio C, mostra nel pavimento del peristilio e della cella molte cavità circolari o quadrate di cui si ignora la funzione. Il Tempio D era dedicato ad Atena (come attesterebbe l'iscrizione dedicatoria IG XIV, 269), piuttosto che non ad Afrodite (TCI). Il grande altare esterno, non in asse col tempio ma posto obliquamente presso il suo angolo SW, fa supporre che l'attuale Tempio D occupi il luogo di uno precedente.
Tempio Y
Detto anche "Tempio delle piccole metope", è preceduto da un altare quadrato. Le metope rinvenutevi (h. cm. 84), databili al 570 a.C., rappresentano: una sfinge di profilo accosciata, la triade delfica (Latona, Artemide, Apollo) in un rigido schema frontale, il ratto di Europa al di sopra del mare; altre due metope databili a ca. il 560 a.C., reimpiegate nelle fortificazioni ermocratee, mostrano la quadriga di Demetra e Kore , ed una cerimonia eleusina con Demetra, Kore ed Ecate con la spiga di grano , sono tutte conservate al Museo Archeologico di Palermo.
Intorno ai Templi C e D vi sono le rovine di un villaggio bizantino di V sec. d.C., costruito con materiale di recupero. Il fatto che alcune case risultavano sepolte dal crollo delle colonne del Tempio C, ha dimostrato che il terremoto che ha portato al crollo dei templi selinuntini deve essere avvenuto in epoca altomedievale.
Verso N l'acropoli presenta due quartieri della città (uno ad W ed l'altro ad E della grande strada N-S), ricostruiti da Ermocrate dopo il 409 a.C.: le case sono modeste, edificate con materiali di recupero; alcune di esse mostrano delle croci incise, segno che furono adoperate come edifici cristiani o da parte di cristiani.
Sulla collina orientale vi sono tre templi che, benché disposti lungo lo stesso asse N-S, tuttavia non sembra avessero un unico recinto sacro (tèmenos), come dimostrerebbe il muro di separazione esistente fra il Tempio E ed il Tempio F. Questo complesso sacro ha fortissime analogie con le pendici occidentali dell'acropoli Caria di Megara Nisea, madrepatria di Selinunte, elemento prezioso, forse indispensabile, per un discorso corretto sull'attribuzione dei culti praticati nei vari templi.
Tempio E

Il Tempio E, il più recente dei tre, risale al 460-450 sec. a.C. ed ha una pianta molto simile a quella dei Templi A ed O dell'Acropoli. Il suo attuale aspetto lo si deve all'anastilosi (ricomposizione e riinnalzamento delle sue colonne) effettuata - tra polemiche - tra il 1956 ed il 1959. Presenta un peristilio (lu. m 67,82; la. m 25,33) di 6 x 15 colonne (h. m 10,19) con numerose tracce superstiti dell'originario stucco che le ricopriva. È un tempio caratterizzato da diverse scalinate che determinano un sistema di rialzamenti successivi: una prima di 10 gradini conduceva all'ingresso sul lato E; dopo il pronao in antis un'altra di 6 gradini conduceva nella cella; e per finire un'ultima di 6 gradini dava accesso - in fondo alla cella - all'adyton; dietro l'adyton, separato da esso, vi era l'opistodomo in antis. Un fregio dorico alla sommità delle pareti della cella era costituito da metope figurate, i cui personaggi avevano il corpo in arenaria locale mentre la testa e le parti nude dei corpi femminili erano in marmo pario; si sono conservate quattro metope intere raffiguranti (in stile severo): Eracle che uccide l'amazzone Antiope; le nozze di Zeus con Hera; Atteone che viene dilaniato dai cani di Artemide; Atena che uccide il gigante Encèlado; inoltre una quinta lacunosa: Apollo e Dafne ; tutte conservate al Museo Archeologico di Palermo. Recenti sondaggi effettuati intorno e al di sotto del Tempio E hanno rivelato che esso è stato preceduto da altri due edifici sacri, di cui uno fu distrutto da un incendio nel 510 a.C. Il Tempio E era dedicato ad Hera, come attesterebbe l'iscrizione di una stele votiva (IG XIV, 271); invece alcuni studiosi (Coarelli-Torelli), in base a confronti, deducono che debba trattarsi piuttosto di un tempio di Afrodite.
Tempio F

Il più antico ma anche il più piccolo dei tre, fu costruito fra il 550 ed il 540 a.C. su modello del Tempio C. È fra i templi quello che maggiormente ha subìto spoliazioni. Presenta un peristilio (lu. m 61,83; la. m 24,43) di 6 x 14 colonne (h. m 9,11) caratterizzato da chiusure in muratura (h. m 4,70) tra gli intercolumni, con finte porte dipinte composte da lesene ed architravi, mentre l'ingresso vero e proprio era ad E. Non si conosce il motivo di questo apprestamento, veramente insolito per un tempio greco: si è pensato che fosse suggerito dalla necessità di proteggere i doni votivi; oppure di impedire ai profani la visione di riti particolari (misteri dionisiaci?) che venivano svolti al suo interno. L'interno è caratterizzato da un vestibolo delimitato da un secondo ordine di colonne, dal pronao, cella ed adyton collegati in un insieme stretto e lungo (carattere arcaico). Dalla facciata E abbiamo due metope tardo arcaiche (datate al 500 a.C.) rinvenute durante gli scavi nel 1823, che rappresentano Atena e Dioniso in atto di colpire a morte due Giganti, oggi conservate nel Museo Archeologico Regionale di Palermo. Il Tempio F era dedicato forse ad Atena (Maiuri, Moscati), forse a Diòniso (Coarelli-Torelli).
 Tempio G
Tempio G

Il Tempio G è il più grande di Selinunte (lu. m 113,34; la. m 54,05; h. m 30 ca.) ed uno dei maggiori del mondo greco[9]. La sua costruzione, pur protraendosi dal 530 al 409 a.C. (si notano variazioni di stile durante il lungo periodo costruttivo: dall'arcaico sul lato E al classico sul lato W), rimase tuttavia incompiuta, come risulta dall'assenza di scanalature in alcune colonne, e dall'esistenza di rocchi di colonne delle stesse dimensioni a km 10 di distanza, in fase di estrazione, nelle Cave di Cusa (vedi sotto). Tra il cumulo terrificante delle sue rovine, si riconosce un peristilio di 8 x 17 colonne (h. m 16,27; diam. m 3,41) di cui sta in piedi una sola - ricomposta nel 1832 - (chiamata "lu fusu di la vecchia"). L'interno comprendeva: un pronao prostilo a 4 colonne con due profonde ante terminanti a pilastro, e tre porte di accesso alla ampia cella; una cella molto larga divisa in tre navate, di cui quella mediana probabilmente "ipetrale" (cioè a cielo aperto) caratterizzata da due file di 10 colonne più sottili che sostenevano una seconda fila di colonne ("galleria"), e da due scale laterali che portavano ai sottotetti; in fondo alla navata centrale, vi è l'adyton separato dalle pareti della cella (soluzione tipica ed originale), all'interno del quale fu ritrovato il torso di un gigante ferito o morente e l'importantissima iscrizione chiamata "Grande Tavola Selinuntina" (vedi più sotto); ed infine un opistodomo in antis non comunicante con la cella. Fra le rovine, di particolare interesse risultano: alcune colonne rifinite che mostrano tracce dello stucco colorato; i blocchi delle trabeazioni che presentano scanalature laterali a ferro di cavallo entro le quali venivano passate le funi per il loro sollevamento. Il Tempio G - che probabilmente aveva anche la funzione di tesoro della città - dall'iscrizione rinvenutavi sembra che fosse dedicato ad Apollo; oggi, in base a studi recenti, si propende ad attribuirlo a Zeus.
Ai piedi della collina, alla foce del fiume Cottone vi è il porto E; esteso per m 600 circa verso l'interno e guarnito probabilmente da un molo o da una diga che si protendeva dall'acropoli, subì nel IV-III sec. a.C. delle trasformazioni: infatti fu allargato e fiancheggiato da banchine (orientate N-S) e da depositi. Dei due porti di Selinunte - attualmente insabbiati - il porto W, posto alla foce del fiume Selino-Modione, era quello principale.
I quartieri extra moenia, collegati alle attività emporiche, commerciali e portuali, erano sistemati invece su grossi terrazzamenti lungo le pendici della collina.
A N dell'attuale villaggio Marinella, infine, si trova una necropoli in località Buffa.